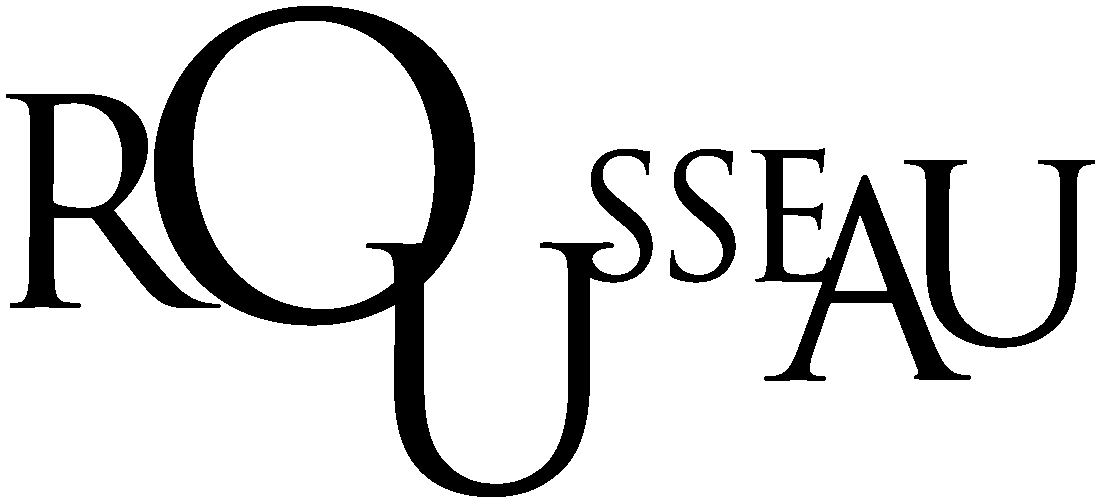di Paolo Madron su Lettera43
Luigi Di Maio che invita il sindacato a riformarsi o ci penserà lui quando sarà al potere ha sollevato una trasversale ondata di indignazione. Con tutti a ricordare come l’autonomia delle confederazioni sia un valore inderogabile, come solo nei regimi autoritari esse siano organiche a chi comanda, come chi rappresenta i lavoratori sia una componente ineludibile della società civile, e via discorrendo.
TANTA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO. Insomma, quando si tocca quel sacro recinto apriti cielo. Non solo gli interessati di difendono inviperiti ma anche la politica, tranne qualche eccezione, si schiera compatta al loro fianco perché, in piena crisi della rappresentanza, non è il caso di mettere a rischio quello che resta ancora un discreto serbatoio di consensi. Qualcuno ha opportunamente ricordato che a puntare il dito contro Camusso e compagnia ci aveva già provato in pieno fervore rottamante Matteo Renzi. Si è visto come è andata a finire, e non certo per colpa dell’ex premier. La resistenza al cambiamento è più ostinata e pervicace che in altri settori della vita pubblica.
Che ora il candidato pentastellato a Palazzo Chigi ci torni sopra è una nota di merito. Innanzitutto dimostra di non avere paura a inimicarsi quel mondo, e in secondo luogo, indipendentemente da chi se ne fa latore, il problema esiste e non ci dovrebbero essere, anche da parte degli interessati, pregiudizi ad affrontarlo. Le questioni sono molte, ma su tutte una: in questi anni di dura crisi economica il lavoro è profondamente cambiato, e chi si erge a suo tutore è sembrato non accorgersene.
UNA CONFEDERAZIONE CHE DIFENDE SOLO SE STESSA. Il sindacato ha continuato a difendere, spesso malamente, chi il lavoro già ce l’aveva, rivelandosi distratto verso la crescente platea di quelli che lo cercavano. Per dirla in uno slogan, ha tutelato il lavoro come rendita di posizione non come legittima aspirazione di chi vi restava escluso. Non bastasse, messo da più parti in discussione, ha reagito nel modo più sbagliato: chiudendosi ancora di più, alzando muri a protezione della sua burocratica autoreferenzialità, riaffermando dal vertice un ruolo che invece solo la basa gli può riconoscere.
Il sindacalismo italiano è così apparso come la stanca ripetizione di se stesso, attraverso ritualità e lessico di un vecchio e logoro repertorio, badando solo a riconquistare un posto fisso al tavolo della concertazione (passata da metodo di confronto a strumento di autodifesa) da cui sembrava dovesse essere escluso. Una volta raggiunto lo scopo, e respinta la minaccia di chi ne denunciava l’anacronistico e corporativo spirito identitario, ha archiviato le spinte al cambiamento, anche quelle che provenivano dal suo interno. Se poi tra i suoi difensori, come scrive Repubblica, rispunta dall’oblio Raffaele Bonanni, l’ex segretario della Cisl che per guadagnarsi una pensione dorata negli ultimi anni di mandato ha vertiginosamente alzato l’asticella del suo stipendio, vuol dire che Di Maio ha proprio ragione.