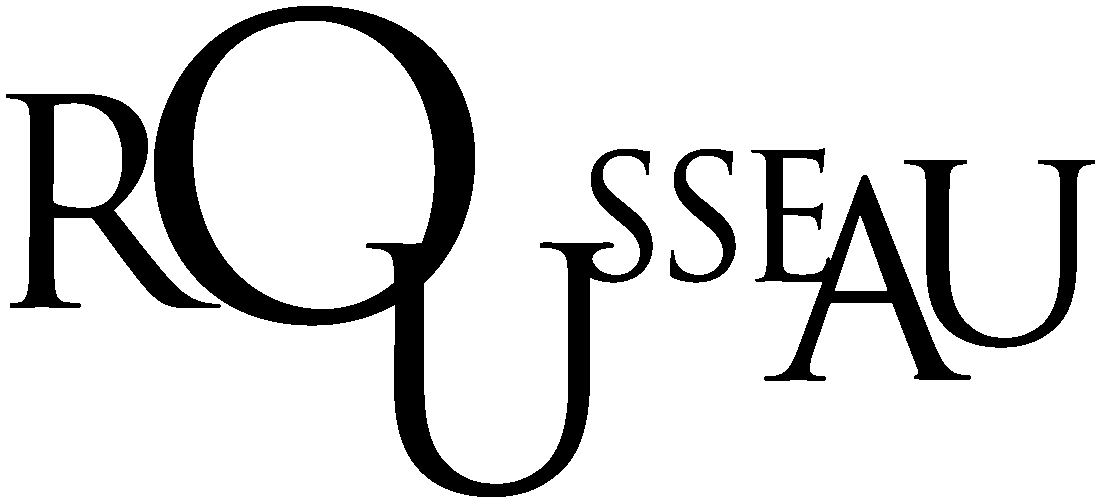di Arianna Giuliodori, Coldiretti
Le scelte, relative alla strategia commerciale internazionale, hanno delle ricadute enormi sui paesi interessati, non solo in termini economici, ma anche sociali e culturali. Le opzioni possibili si muovono tra due estremi: da un lato, il liberismo assoluto, e dall’altro il protezionismo totale, ribattezzato di recente neo-sovranismo. Nel primo caso, quello del liberismo, si tratta di procedere alla rimozione completa, e il più possibile rapida, di tutte le barriere che si oppongono al commercio, che si tratti di barriere tariffarie, i dazi, oppure di barriere non tariffarie, come ad esempio le misure sanitarie e fitosanitarie che sono imposte sui prodotti alimentari. I sostenitori di questo approccio si definiscono amanti del free trade, del libero commercio, ma non si tratta di libertà, si tratta piuttosto di una deregolamentazione assoluta, di una forma di competizione selvaggia e senza limiti che sfocia nel travolgimento delle distintività locali, nell’omologamento al ribasso della qualità e spesso nella cancellazione delle identità culturali, a favore dei grandi e a scapito dei più piccoli.
I rischi di questa logica sono talmente evidenti che persino i paladini del libero commercio, come il WTO, l’organizzazione mondiale del commercio, il Fondo Monetario Internazionale, o ancora la Banca Mondiale, hanno di recente pubblicato uno studio in cui ammettono che l’apertura internazionale al commercio può comportare per le persone e per i territori la perdita di posti di lavoro e crisi economica, se non gestita adeguatamente. All’opposto, l’altro caso è quello del neo-sovranismo, cioè del protezionismo totale. In questo caso ci si concentra su una forma di autarchia, dove la produzione e il consumo si realizzano interamente all’interno del paese. Secondo alcune interpretazioni ciò permette di salvare dei posti di lavoro a livello internazionale. Tuttavia questo comporta anche un aumento dei prezzi a scapito dei consumatori, e una penalizzazione delle esportazioni, che nel caso di un paese come l’Italia può rappresentare una minaccia. Ultimamente questo è comunque un approccio che trova molti sostenitori sulla scena internazionale, e non da ultimo il presidente americano Trump.
C’è infine un terza via, che punta a trovare un equilibrio tra l’apertura al commercio internazionale e la protezione degli interessi dei cittadini, siano essi economici o sociali. Se pensiamo al settore che rappresenta Coldiretti, l’agricoltura, l’agroalimentare, il mercato è sicuramente importante e lo diventa sempre più, se pensiamo che l’Italia, nel 2016, è stata capace di esportare beni alimentari per un valore di 38 miliardi di euro, e che questo valore è destinato ad aumentare nel corso del 2017. Ma il mercato non è tutto, perché bisogna tenere in considerazione profili legati all’ambiente, alla salute, alla sicurezza, ai diritti delle persone; e invece il mercato relega tutto ciò nella nozione semplicistica di prezzo più basso’, che anche a causa di regole spesso asimmetriche permette di realizzare forme di dumping, che contribuiscono ad esempio alla deforestazione, alla produzione di cibo spazzatura, e allo sfruttamento del lavoro, anche minorile. Ma la nostra storia, le tradizioni, il paesaggio, la cultura, non possono essere ridotti e azzerati nel concetto di mercato, soprattutto quando questo ha l’ambizione ad essere globale.
Prima del mercato, vengono le persone, ecco perché ad esempio, nella logica dei trattati di libero scambio si dovrebbe inserire il rispetto dei diritti dei lavoratori, ma così non è. Ce lo testimonia il 5° rapporto agromafie promosso da Coldiretti ed Eurispes, secondo il quale i prodotti che entrano in Europa spesso nascondono una forma di caporalato invisibile, invisibile semplicemente perché si realizza in paesi lontani. E per non restare sul vago, cerchiamo di dare un esempio: il pomodoro cinese. Nel 2016 abbiamo importato circa 100 milioni di kg di pomodoro concentrato dalla Cina, che rappresenta più o meno il 10% di quanto l’Italia produce, con un aumento di oltre il 43%. Eppure, in Cina ci sono numerose denunce del ricorso a dei veri e propri campi lager agricoli, i Laogai, per la produzione di questo prodotto.
Ma quando poi il prodotto arriva sui nostri scaffali, complice la totale mancanza di trasparenza dell’etichettatura, si rischia di trasformarlo in vero e proprio made in Italy bagnato del sangue del lavoro di veri e propri schiavi. In conclusione, per questa terza via non si dovrebbe parlare di libero commercio, ma di commercio libero e giusto, che si fonda su delle regole certe e soprattutto sul rispetto delle persone.