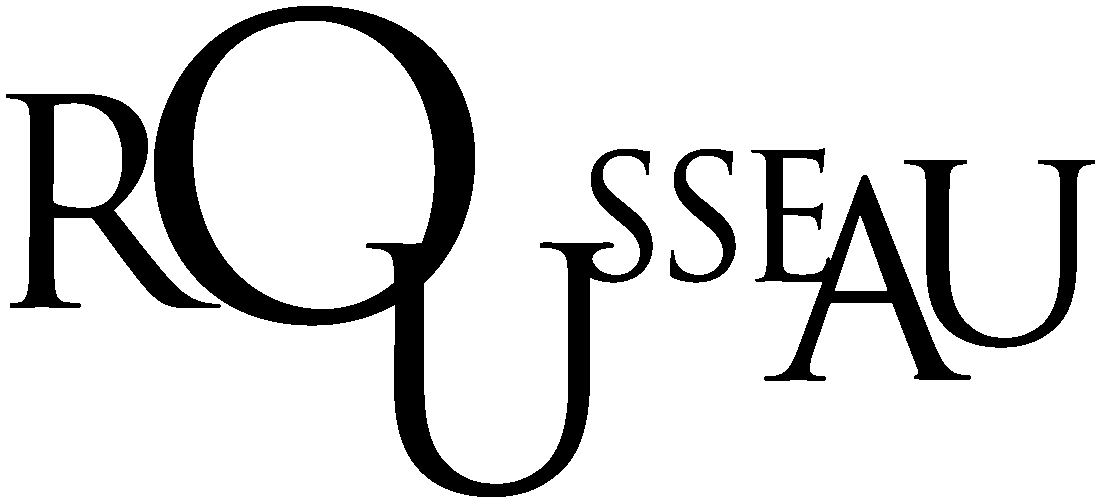>>> Hanno votato per il programma Esteri 23.481 iscritti certificati che hanno espresso 69.891 voti. Di seguito i dettagli:
Contrasto ai trattati internazionali come TTIP e CETA 14.431
Sovranità e indipendenza 10.693
Un’Europa senza austerità 8.529
Ripudio della guerra 6.814
Smantellamento della Troika 6.589
Disarmo come premessa alla pace 5.548
Russia: un partner economico e strategico contro il terrorismo 5.324
Riformare la NATO 4.547
Risoluzione dei conflitti in Medio Oriente 4.219
Nuovi scenari di alleanze per l’Italia 3.197
Per Lucca hanno votato 94 iscritti. Bindocci Massimiliano ha ricevuto 52 voti e Buccianti Fabrizio 42.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. <<<
Alcuni giorni fa in Senato, PD, NCD, FI e Lega Nord hanno salvato dalla decadenza il Sen. Minzolini, nonostante su di lui penda sin dal 2015 una sentenza di condanna definitiva per peculato e l’interdizione dai pubblici uffici. Avrebbero dovuto solo applicare la Legge Severino ed invece l’hanno palesemente violata. Così come è stato violato il principio costituzionale dell’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Abbiamo chiesto, dunque, al Prof. Valerio Onida (giurista italiano, Giudice della Corte Costituzionale dal 1996 al 2005, Presidente della Corte Costituzionale dal 2004 al 2005 e professore di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano) quali fossero le sue osservazioni in merito alla decisione del Senato. Ecco la sua risposta che pubblichiamo integralmente. Ringraziamo il Prof. Onida per la sua disponibilità.
di Valerio Onida
Il voto del Senato sulla decadenza del sen Minzolini è ovviamente legittimo sul piano formale (a ciò era chiamata l’aula, dopo l’istruttoria e la proposta della Giunta delle elezioni, come sempre accade quando si tratta di dirimere una questione di ineleggibilità: art. 66 Cost.): ma nella sostanza si è trattato di una delibera contraria alla legge (al decreto legislativo emanato in base alla legge “Severino”), e che contraddice perciò questa legge pur approvata a suo tempo dal Parlamento.
Infatti la legge dice che “non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore”, fra l’altro, “coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione” per delitti commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si tratta dunque di una causa sopravvenuta di ineleggibilità prevista dalla legge, e al Senato spettava solo accertarla e trarne le conseguenze dichiarando la decadenza del senatore condannato.
La legge dice ancora che quando la causa di “incandidabilità” sopravvenga “nel corso del mandato elettivo”, la Camera di appartenenza “delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione”: quello in base al quale ciascuna Camera giudica, fra l’altro, “delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”.
Si dice: ma se è il Senato a giudicare, allora esso poteva decidere come voleva. No: “giudicare”, secondo la precisa terminologia dell’art. 66 della Costituzione, non vuole dire decidere discrezionalmente, ma dirimere una controversia concreta applicando la legge. Come fa ogni giudice, che è appunto “soggetto alla legge” (art. 101 della Costituzione). Cosa direste di un giudice che decidesse le cause di propria testa, secondo il proprio arbitrio, senza aver riguardo a ciò che prevede la legge?
Nel caso, la legge è chiarissima nello stabilire come presupposto della incandidabilità (ineleggibilità) sopravvenuta una cosa sola: l’esistenza di una sentenza definitiva, cioè non più impugnabile, del giudice penale che condanni l’interessato a una certa pena, per un certo tipo di reato. Questo il Senato era chiamato ad accertare, traendone obbligatoriamente, in caso di accertamento positivo, la conseguenza della dichiarazione di decadenza. Il Senato invece non ha negato che vi fosse il presupposto legale della decadenza: ha semplicemente rifiutato di dichiararla.
Che si trattasse di un vero e proprio giudizio, da condurre secondo la legge, risulta anche dal fatto che il procedimento si è svolto, come doveva, nel contraddittorio con l’interessato (il sen. Minzolini e il suo avvocato hanno infatti partecipato al procedimento davanti alla Giunta delle elezioni incaricata dell’istruttoria, sostenendo le loro tesi) e addirittura anche con colui che, se il sen. Minzolini fosse decaduto, avrebbe avuto diritto di subentrare a lui in Senato come primo dei non eletti nella stessa lista (il quale però ha rinunciato a comparire).
Ma allora perché affidare al Senato, anziché a un giudice “vero” (terzo e imparziale) la soluzione della controversia? Perché l’articolo 66 della Costituzione, in omaggio ad una antica tradizione, ha voluto assicurare al massimo grado l’autonomia delle Camere anche quando si tratta di dirimere controversie giuridiche riguardanti la loro composizione: perché in antico il Parlamento era geloso della propria indipendenza rispetto al Sovrano, da cui non erano del tutto indipendenti invece i giudici. Questa forma di autonomia è oggi un poco anacronistica, e infatti sarebbe auspicabile prevedere, per esempio, che a decidere in ultima istanza su tale tipo di questioni debba essere un organo imparziale, come la Corte costituzionale (riformando l’art. 66 della Costituzione). Ma ciò non significa comunque che oggi le Camere possano decidere (giudicare) su tali questioni secondo il loro arbitrio: anch’esse debbono applicare la legge che prevede i requisiti di eleggibilità e le cause di ineleggibilità sopravvenute.
Se poi il Parlamento non fosse più d’accordo su ciò che dispone la legge, la dovrebbe cambiare: non disapplicarla in un caso concreto, creando così una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri casi simili (si pensi al caso Berlusconi).
In realtà almeno alcuni dei senatori che hanno votato contro la decadenza del sen. Minzolini tra i quali si trovano persone, come il sen. Luigi Manconi, ben noti per il loro meritorio costante atteggiamento a difesa dei diritti fondamentali devono essere incorsi in un equivoco: scambiando la votazione, a cui erano chiamati a partecipare in vista della applicazione della legge Severino, per un voto nel quale il Senato fosse chiamato a decidere liberamente, in base ad un apprezzamento discrezionale, e quindi anche ad un apprezzamento delle circostanze e dei modi in cui era intervenuta la condanna, se fosse o meno il caso di dichiarare la decadenza del sen. Minzolini.
Qualcuno infatti ha evocato il fumus persecutionis: cioè il sospetto, basato sull’esame degli atti giudiziari, che la condanna penale del sen. Minzolini sia stata il frutto non della corretta applicazione della legge, ma di una “persecuzione giudiziaria” magari collegata alla posizione politica del senatore: quindi una condanna ingiusta, non conseguente ad un equo processo.
Di fumus persecutionis si parla abitualmente quando le Camere sono chiamate ad esercitare la prerogativa, loro riconosciuta dalla Costituzione, di autorizzare o meno il compimento di atti giudiziari nei confronti di un loro componente. Fino al 1993 la Costituzione sottoponeva ogni iniziativa giudiziaria diretta a procedere penalmente nei confronti di un parlamentare alla preventiva autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza: proprio a difesa assoluta dell’autonomia delle Camere e a difesa dei parlamentari da possibili iniziative giudiziarie “persecutorie”. In quel contesto, la Camera era chiamata a decidere discrezionalmente se autorizzare o meno il procedimento penale, in base al riscontrato o meno fumus persecutionis.
Dal 1993 la Costituzione è stata modificata, sull’onda degli scandali di Tangentopoli, eliminando la necessità dell’autorizzazione a procedere (ora quindi anche i parlamentari possono essere processati e condannati senza lo “scudo” prima apprestato dalla Costituzione). E’ rimasto però (art. 68 della Costituzione) il divieto per la giustizia di disporre l’arresto di un parlamentare, o una intercettazione a suo carico, senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza: anche in questo caso si tratta di una determinazione discrezionale dell’assemblea, che è libera di concedere o di negare l’autorizzazione, valutando gli atti e ogni circostanza. Ma c’è una eccezione: non è richiesta l’autorizzazione per procedere all’arresto del parlamentare in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna (o quando sia colto in flagranza nell’atto di commettere un delitto per il quale è prescritto l’arresto obbligatorio).
Dunque, in base alla Costituzione, quando interviene una sentenza definitiva della magistratura, che condanna un parlamentare a pena detentiva, la Camera di appartenenza non può impedirne l’arresto, nemmeno se ritenesse la sentenza di condanna “ingiusta”. Il che mostra come, di fronte alla pronuncia irrevocabile del giudice, nemmeno la prerogativa parlamentare possa consentire al componente di una Camera di sfuggire alle conseguenze che da essa derivano per legge. Paradossalmente, il sen Minzolini potrebbe essere arrestato, se la sua condanna comportasse l’esecuzione di una pena detentiva; senza che il Senato possa impedirlo: ma la sua decadenza dal seggio parlamentare è stata negata, nonostante che, in base alla legge, essa costituisca una conseguenza necessaria della stessa condanna.
In questo caso dunque non vi è luogo a parlare di fumus persecutionis, che potesse in ipotesi giustificare la delibera del Senato. C’è già la sentenza, ed essa è definitiva: non vi era da autorizzare niente, ma si trattava solo di trarre le conseguenze della applicazione rigorosa della legge, che comportava la decadenza.
Che dire allora dei dubbi che in Senato sono stati sollevati sulla correttezza del procedimento penale subìto dal sen. Minzolini e dunque sulla correttezza della condanna che ne è conseguita, dubbi che, a quanto è emerso, hanno persuaso alcuni senatori a negare la decadenza?
I dubbi si incentravano essenzialmente su due aspetti. Il primo era dato dal fatto che il sen. Minzolini, che era stato prosciolto in primo grado, è stato poi invece condannato in appello (con la conferma poi da parte della Corte di cassazione) senza però che la Corte d’appello ritenesse necessario riaprire l’istruttoria dibattimentale sentendo nuovamente i testimoni. Oggi la nostra legge processuale lo consente, quando il giudice d’appello ritenga che le risultanze di fatto siano interamente accertate e si tratti solo di valutarne la portata probatoria sulla base degli atti. C’è chi, forse con qualche ragione, contesta tale regola in nome della massima garanzia di un equo processo, e in Parlamento si è proposta sul punto una modifica. Ma è evidente che, allo stato, ciò non inficia in nulla gli effetti della sentenza definitiva, avallata dalla Cassazione.
Ancora, si è osservato che del collegio della Corte di appello che ha pronunciato la condanna del sen. Minzolini (poi avallata dalla Cassazione) faceva parte un magistrato che in passato era stato (ovviamente quando era collocato in aspettativa) sottosegretario in un Governo Prodi, manifestando così la sua posizione politica, si suppone, contraria a quella del gruppo in cui milita il sen. Minzolini. Non era stato però “ricusato” (l’imputato può ricusare il giudice che non appaia imparziale in base a precisi elementi definiti dalla legge) né aveva chiesto di potersi astenere dal giudizio per “gravi ragioni di convenienza”. Forse sarebbe stato meglio che il giudizio si fosse svolto senza la sua partecipazione. Ma, ancora una volta, tutto ciò non inficia in nulla, sul piano giuridico, la sentenza definitiva di condanna, che non è “sindacabile” da alcuna altra istanza, salvo l’eventuale ricorso dell’interessato alla Corte di Strasburgo.
In definitiva, non esisteva nessun motivo legalmente plausibile perché il Senato potesse rifiutarsi di applicare la legge. E invece questo è ciò che il Senato ha fatto, decidendo contro la decadenza del sen. Minzolini.
Non c’è rimedio? La decisione del Senato non è sindacabile davanti a nessun giudice comune. Peraltro, a questo punto logica vorrebbe che il Parlamento abrogasse la norma di legge che prevede la causa sopraggiunta di incandidabilità e dunque la decadenza nelle ipotesi in questione.
In astratto si potrebbe immaginare un conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato che ha esorbitato dalle sue funzioni. Ma non si è realizzata la compromissione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere dello Stato, che è il presupposto per poter sollevare il conflitto davanti alla Corte costituzionale. Infatti l’applicazione della legge sulla incandidabilità sopravvenuta non concerne le attribuzioni dell’autorità giudiziaria, né l’applicazione delle statuizioni di questa. Queste comportano di per sé solo l’esecuzione della pena, mentre la conseguenza ulteriore della condanna, che riguarda la perdita dell’eleggibilità e quindi la decadenza, non è una sanzione penale ma riguarda il diverso tema del venir meno delle condizioni alle quali la legge ha collegato il diritto di ricoprire e mantenere la carica elettiva.
Quindi nessun possibile conflitto: ma solo la presa d’atto di una violazione da parte del Senato del principio di legalità.
Che poi si possa porre il problema di prevenire e contrastare iniziative o atti di singole autorità giudiziarie suscettibili eventualmente di violare i principi dell’eguaglianza, dell’imparzialità e dell’equo processo, e l’obbligo di non utilizzare il potere giudiziario a fini politici di parte, è vero: e forse oggi il tema meriterebbe maggiore attenzione. Ma i rimedi non stanno nell’esercitare altri poteri violando la legge, né tanto meno nel costruire nuove forme di asservimento del potere giudiziario ai poteri politici: stanno, oltre che nell’impiego degli strumenti interni al sistema processuale, nel miglioramento delle leggi processuali; nella migliore formazione dei magistrati e nella organizzazione dell’apparato giudiziario, specie per quanto riguarda gli uffici delle Procure; nella sensibilità della politica e dell’opinione pubblica al tema delle garanzie e degli eventuali errori giudiziari; oltre che, se del caso, all’attivazione degli strumenti di controllo sovranazionali, come il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea.