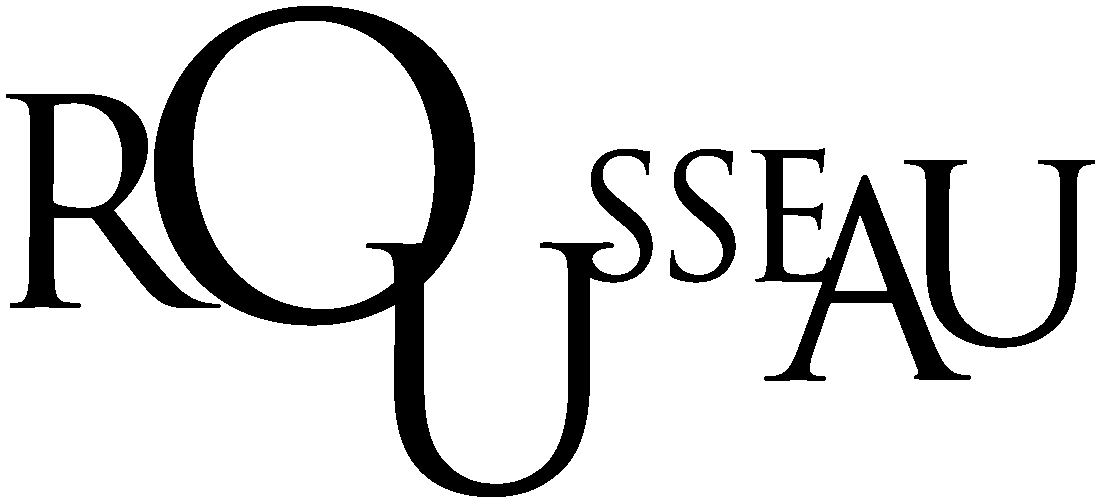di Valerio Onida, giurista, giudice costituzionale dal 1996 al 2005, Presidente della Corte costituzionale dal 22 settembre 2004 al 30 gennaio 2005 e professore di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano
Il decreto legislativo n. 235 del 2012 emanato sulla base della delega conferita dalla “Legge Severino”, n. 190 del 2012 – stabilisce, all’articolo 1, che «non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore», fra l’altro, «coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione» per delitti commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. L’art. 3 dello stesso decreto legislativo stabilisce che qualora la causa di “incandidabilità” sopravvenga «nel corso del mandato elettivo», la Camera di appartenenza «delibera ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione: quello in base al quale «ciascuna Camera giudica», fra l’altro, «delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”. Si noti che la legge di delega, nello stabilire i criteri direttivi cui il decreto doveva attenersi, precisava in modo inequivoco che si dovevano disciplinare le ipotesi di «decadenza di diritto» dalle cariche nel caso di condanna definitiva sopravvenuta nel corso del mandato.
La legge è dunque chiarissima: la condanna definitiva comporta la decadenza di diritto dalla carica, destinata ad essere solo accertata e dichiarata dalla Camera di appartenenza del parlamentare.
Vi è da dubitare che i senatori che hanno votato contro la decadenza del sen. Minzolini abbiano letto davvero la lunga e motivata relazione con cui la Giunta delle elezioni aveva escluso che si potesse esimersi dal dichiarare tale decadenza; e ancor prima abbiano letto la Costituzione. Questa infatti non dà alle Camere il potere di decidere liberamente, in base ad apprezzamenti discrezionali o politici, se dichiarare o meno l’esistenza di una causa sopravvenuta di ineleggibilità, e quindi di dichiarare o meno la decadenza del condannato, ma solo il potere-dovere di “giudicare”, sulla base della legge, se la causa di decadenza contestata sussista o non sussista. Sempre se avessero letto gli atti, quei senatori si sarebbero accorti che il sen. Minzolini non si difendeva negando (non poteva farlo) che sussistesse formalmente nella specie l’ipotesi prevista dalla legge per la decadenza, ma, prima di tutto, contestando la legittimità costituzionale della stessa legge Severino se applicata a persone condannate per fatti commessi prima della sua entrata in vigore (è la stessa eccezione sollevata a suo tempo da Berlusconi e non accolta dal Senato): al che la maggioranza della Giunta ha opposto che l’ineleggibilità non è una sanzione penale, che non potrebbe essere applicata retroattivamente, ma comporta l’assenza di un requisito previsto dalla legge per accedere o mantenere la carica.
Inoltre il sen. Minzolini lamentava che la sua condanna fosse intervenuta in appello (e confermata dalla Cassazione) dopo che in primo grado egli era stato prosciolto, senza che la Corte d’appello avesse riaperto l’istruttoria; e che nel giudizio d’appello uno dei componenti del collegio era stato, in passato, sottosegretario in un Governo di schieramento avverso a quello dello stesso sen. Minzolini (ma non era stato ricusato dall’imputato né aveva ritenuto esistessero motivi per astenersi dal giudicare).
Ora, tutto ciò avrebbe potuto al massimo condurre il Senato, se avesse condiviso il dubbio di costituzionalità della legge, a sollevare la relativa questione davanti alla Corte costituzionale (la quale peraltro si è già pronunciata, implicitamente, in senso contrario in altre occasioni, come ha ricordato la Giunta). Il Senato, quando “giudica”, ai sensi dell’art. 66 della Costituzione, sulle cause di ineleggibilità, potrebbe bensì, come qualsiasi giudice, investire la Corte costituzionale del dubbio, ma non può disapplicare la legge di propria iniziativa. Si potrà dire che, essendo “giudice” di unica istanza, se lo fa non c’è rimedio. Ma resta il fatto che la delibera è contra legem: se il Parlamento ritenesse che una legge non debba essere applicata perché inopportuna, la dovrebbe modificare (sopprimendo così per tutti la causa di ineleggibilità e di decadenza), e non violarla nel caso concreto (e in modo discriminatorio).
Ancor meno vale come giustificazione del voto del Senato la tesi secondo cui nel caso del sen. Minzolini il processo che ha dato luogo alla sua condanna non sarebbe stato “giusto“.
Le Camere, quando sono chiamate a “giudicare” su un caso di decadenza verificatosi in forza di una sentenza definitiva, non hanno e non possono esercitare alcun controllo sulla correttezza giuridica della sentenza stessa: la legge infatti collega la decadenza al fatto che sia intervenuta una condanna definitiva, non attribuisce alle Camere un controllo sulla attività dei giudici.
Così si è sentito taluno giustificare il voto contrario in base al fatto che nella specie la Corte d’Appello non avrebbe dovuto rovesciare il giudizio di proscioglimento emesso dal Tribunale senza riaprire l’istruttoria. Ciò non è oggi prescritto della legge (almeno quando si discuta non della credibilità di un dichiarazione accusatoria ma della sussistenza di prove sufficienti sulla colpevolezza); e infatti taluno propone di modificarla sul punto. Ma se anche si volesse (e non lo escludo) condividere la critica alla legge attuale, sta di fatto che qui non si trattava di cambiare la legge processuale, ma di trarre le conseguenze legalmente dovute da una sentenza definitiva pronunciata secondo la legge in vigore.
Clamorosa è poi la contraddizione di chi ha apertamente giustificato il proprio voto contrario rilevando un presunto fumus persecutionis nella vicenda giudiziaria del sen. Minzolini.
Il fumus persecutionis è il dubbio che può giustificare, e talora giustifica, l’uso di un potere discrezionale spettante alle Camere nel concedere o meno una autorizzazione (un tempo a procedere, oggi ad arrestare o a intercettare) che condiziona legalmente l’iniziativa dell’autorità giudiziaria. Ma nel caso non di questo si tratta: il processo si è svolto fino in fondo e c’è un sentenza definitiva, e al Senato spettava solo trarne le conseguenze applicando la legge, non sindacare se la sentenza definitiva sia stata “giusta”. Una pretesa di questo genere sarebbe eversiva. Secondo la Costituzione, nemmeno all’arresto del parlamentare condannato definitivamente a pena detentiva la Camera potrebbe opporre un diniego sostenendo che la condanna sia “ingiusta” (art. 68, secondo comma, Cost.).
Che vi possano essere legittimi dubbi su certe iniziative giudiziarie che toccano i “politici” (e non solo) è vero. Ma allora la risposta sta nel modificare le leggi assicurando il “giusto processo” (art. 111 Cost.), e nell’organizzare l’esercizio della funzione giudiziaria (soprattutto delle Procure) in modo da garantirne meglio la legalità e l’imparzialità, e da scongiurare o correggere iniziative scorrette: non può consistere nel creare “zone franche”
fonte: Il Sole 24 Ore