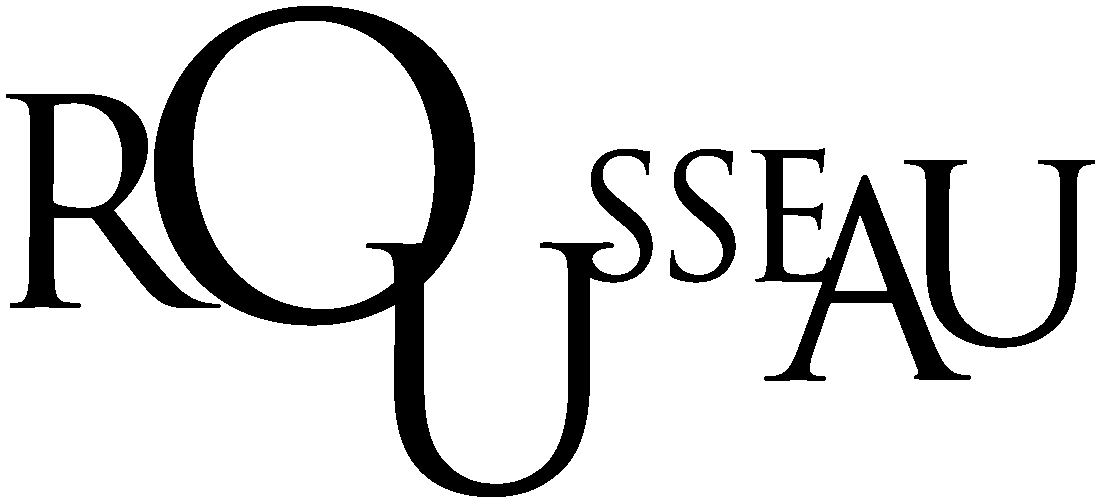“È piccolo il carcere di Livorno. Piccolo e dimenticato, ma dentro grande è la disperazione, l’abbandono. Le mura del carcere più che imprigionare sembrano voler impedire che si sappia cosa accade lì. Ho passato anni in una cella di dieci metri quadri. Dentro ci stavamo in sei e a volte sette. Uno sopra l’altro. Si stava in una condizione invivibile, lo spazio per muoverci era minimo, si faceva a turni per alzarsi dalla branda ed eravamo costretti a stare chiusi in quella cella per ventun ore al giorno. L’ora d’aria in un cortiletto era l’appuntamento più atteso del giorno. Dal cesso usciva la merda, soprattutto di notte come un rigurgito delle fogne, e la salsedine del mare faceva marcire tutto: mura, sbarre e noi stessi detenuti esposti a un’umidità che ci spaccava le ossa. Tra di noi c’erano anche ragazzi stranieri. Poveracci. Sono loro che, senza neanche poter usare la parola, se la vedono peggio. Li vedi in silenzio per giorni e giorni, poi all’improvviso te li trovi per terra in cella con le braccia tagliate, in una pozza di sangue. In carcere c’è un metodo per tutto, anche per farsi più male con una lametta. Un capitolo a parte è il regime di disciplina. Alle guardie non si può chiedere nulla. Questa è la regola per sopravvivere lì dentro. Stare zitto. Se un detenuto domanda anche un semplice foglio di carta o una medicina rischia la cella liscia. La scena è questa: tu chiedi una cosa, l’agente arriva e ti risponde male. A quel punto se stai zitto, va tutto bene ma se reagisci ti menano lì o ti portano nella cella liscia. Io una volta ci sono stato. Una sera di novembre sono arrivati in cinque, mi hanno preso, mi hanno portato giù nella cella liscia. Mi hanno fattro spogliare. Per sei giorni sono rimasto nella cella di isolamento in mutande. Dormivo su un materasso buttato a terra e senza una coperta. Nudo, rannicchiato su quel materasso non sapevo più cosa ero. In quella cella non puoi chiedere aiuto perché loro chiudono anche il blindato, che è una porta di ferro. Nessuno ti può sentire. O meglio, devi sperare che non ti senta nessuno, perché il peggio deve arrivare. Una notte mi misi ad urlare e mi hanno sentito. Pochi minuti di silenzio, poi uno sbattere di cancelli e un rumore di passi pesanti sempre più forte. Mi sono messo in un angolo della cella per cercare riparo. Sono entrati e mi hanno picchiato. Erano sei o sette guardie, con guanti e con gli scarponi che in cima hanno il ferro. Mi hanno spaccato la faccia. Il mio non è un caso isolato, non ero il solo nel carcere di Livorno a subire questo trattamento. Ho visto tanti detenuti presi e portati via. Quando tornavano in cella avevano i lividi addosso, spaccati in faccia e gli occhi pesti. Una cosa va detta, ed è che il problema non sono le guardie, è che quando metti così tanta gente insieme è ovvio che si degeneri. Devi stare zitto, altro che rieducazione. Silenzio o botte. Difficile in un posto come il carcere di Livorno capire chi è vittima e chi è carnefice, cosa è giusto o cosa non lo è. Ci si scontra, come auto nella nebbia.” Mario, 43 anni
Lettera dal carcere tratta da Fenix